
Raccogliere i frutti di un cammino di conversione e di riforma per rendere più bello e vero il volto bimillenario della Chiesa. È questo quello che ci si attende dai lavori della seconda Sessione Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che sta per concludersi a Roma proprio in questi giorni. Lo stesso frutto ci si attende anche dalla conclusione della fase profetica del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, il quale vedrà il suo apice di discernimento comunitario nelle due assemblee sinodali che si celebreranno a Roma a novembre e ad aprile prossimi.
Tutti ci stiamo chiedendo però se questi frutti ci saranno veramente. Cambierà qualcosa? O avremo solo perso degli anni ad inseguire il sogno di una Chiesa diversa, più capace di rispondere alle sfide del nostro tempo ma, alla fine, rimasta totalmente ripiegata su se stessa?
Una sinergia virtuosa
Attese e preoccupazioni assolutamente legittime e che, per certi versi e su certi temi, rischiano di essere quasi sicuramente disattese. Attese e preoccupazioni, però, che possono portare con loro anche il rischio di una grande illusione: pensare che bastino i pronunciamenti di un’assemblea sinodale a far cambiare davvero la Chiesa, che sia sufficiente la decisione di qualcuno – solitamente al vertice – affinché si realizzi una riforma. Certo, su alcune questioni e in certe circostanze è necessaria la decisione di qualcuno, ma non è sufficiente! Non solo perché, come in questo caso, l’assemblea sinodale (compresa quella italiana!) non ha, per sua natura, un potere decisionale così direttivo, quanto piuttosto il compito di operare un discernimento e maturare il consenso per orientare ad una decisione. Ma anche perché nella Chiesa – come in qualsiasi altra istituzione – non c’è un rapporto di causa effetto tra una scelta presa e il cambiamento effettivamente realizzato. Perché una riforma avvenga è necessario che si inneschi una sinergia virtuosa tra i soggetti che compongono l’istituzione, le sue forme istituzionali e i processi formativi orientati al raggiungimento di questo cambiamento. Nessuna conversione o riforma può limitarsi ai soli soggetti, come alla sola istituzione o alla sola formazione. Sarebbe monca degli elementi essenziali alla sua trasformazione. Il rischio sarebbe quello di avere semplicemente un cambiamento formale ma non sostanziale. Non è un caso che la storia della Chiesa ci insegni quanto sia lunga e laboriosa la recezione di un Concilio e che, in alcuni contesti spazio-temporali, essa non avviene mai (totalmente)! Anche oggi siamo spettatori di questa fatica: le resistenze alla sinodalità della Chiesa non sono altro che le resistenze ad un modello ecclesiologico scelto dal Vaticano II e mai attuato fino in fondo.
Seppur nei limiti di questa nostra riflessione, cerchiamo di descrivere almeno i tratti caratterizzanti questa sinergia virtuosa protesa al cambiamento.
I soggetti del cambiamento
La riforma «deve radicarsi in una trasformazione interiore secondo i “sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5). Per una Chiesa sinodale, la prima conversione è quella dell’ascolto» (Instrumentum laboris 2024, n. 19). Il richiamo dello strumento di lavoro alla trasformazione interiore è un passaggio fondamentale per comprendere qual è il compito dei soggetti protagonisti di questo processo: operare un cambiamento di mentalità. Perciò, afferma il documento, la prima conversione è l’ascolto. Bisogna ascoltare dentro di sé i modelli che guidano l’interpretazione della realtà ecclesiale e del mondo, le precomprensioni e le proprie paure, la propria esperienza di fede e la modalità di relazione con gli altri. Senza questo prezioso ascolto non ci può essere riconoscimento della propria realtà e dunque neanche cambiamento di mentalità. Perciò i soggetti hanno un ruolo fondamentale, ciascuno a partire dal posto peculiare che occupa nella compagine ecclesiale. Se un fedele non percepisce la sua dignità battesimale e quanto questa fondi la sua corresponsabilità nella vita della comunità, difficilmente darà il suo contributo a realizzare un modello ecclesiale partecipativo, dove il discernimento è di tutti e le decisioni frutto del consenso. Così come se un pastore – vescovo o presbitero – avrà in mente un modello esclusivamente gerarchico della Chiesa, non potrà facilmente avallare la presenza ministeriale dei laici e, ancor meno, sarà portato a riconoscere un ruolo di leadership alle donne, al di là di ogni posizione dottrinale (spesso usata come un facile schermo).
Una volta terminato il Sinodo universale o il Cammino sinodale in Italia, ciascuno dei soggetti ecclesiali dovrebbe chiedersi: in che modo mi sto rendendo ostacolo o strumento efficace per concretizzare quanto è stato deciso? Io, vescovo, sto esercitando la mia autorità a servizio delle scelte comuni o sto piuttosto bloccando il processo? Io, fedele, mi sto deresponsabilizzando pensando che certe cose non dipendano da me o do il mio contributo? Io, presbitero o diacono, resto fedele ai miei modelli ecclesiali, al “si è sempre fatto così” o scelgo di essere fedele a questo cammino di Chiesa e mi lascio provocare dal cambiamento, anche se mi spaventa o mi scomoda?
Forme istituzionali mutabili?
«Spetta alle Chiese locali dare crescente attuazione a tutte le possibilità di dare vita a processi decisionali autenticamente sinodali, appropriati alle specificità dei diversi contesti. Si tratta di un compito di grande importanza e urgenza, in quanto da esso dipende largamente il buon esito della fase attuativa del Sinodo. Senza cambiamenti concreti, la visione di una Chiesa sinodale non sarà credibile e questo allontanerà quei membri del Popolo di Dio che dal cammino sinodale hanno tratto forza e speranza» (Instrumentum laboris 2024, n. 71).
A nulla serve una conversione personale se ad essa non corrisponde una revisione strutturale della vita della Chiesa. Attualmente, qui risiede forse uno dei nodi più problematici nei processi di riforma ecclesiale. È noto: nessuna istituzione attraversa a cuor leggero dei cambiamenti. Ma fino a quando le scelte non si traducono in forme concrete, nulla può cambiare. Ad esempio, come è possibile affermare l’importanza del sensus fidei dei battezzati nel discernimento comunitario se non si rendono obbligatori gli organismi di partecipazione in cui questo avviene? O come è possibile accogliere chi è stato messo ai margini della vita comunitaria senza creare spazi e luoghi precisi in cui questo possa visibilmente avvenire? Saremmo di fronte ad un cambiamento formale al quale non corrisponde un cambiamento sostanziale.
Una istituzione – lo afferma l’etimologia del termine (institutio) – è un organismo nato per preservare un fine. Quando questo non avviene essa ha il dovere di modificarsi. Purtroppo, troppe volte ci si rifugia in forme istituzionali rassicuranti, sempre adatte a placare le ansie che il nuovo porta con sé. Così si finisce per identificare pericolosamente l’istituzione con se stessi, perdendo lo sguardo oggettivo su di essa. Non si riconosce più quando una struttura ecclesiale sta offuscando il fine, anziché aiutare a raggiungerlo. Identificare se stessi con l’istituzione è sempre un’operazione pericolosa perché fa perdere la prospettiva del servizio, l’unica in grado di il giusto distacco che permette scelte adeguate al bene della missione della Chiesa e non al proprio punto di vista.
Processi formativi trasformativi
«Rispondere alla domanda “Come essere Chiesa sinodale in missione?” richiede dunque di dare priorità alla predisposizione di percorsi formativi coerenti, con particolare attenzione alla formazione permanente per tutti» (Instrumentum laboris 2024, 51).
C’è un ingranaggio vitale del processo di riforma spesso ignorato: la formazione. Essa è indispensabile perché chi opera nell’istituzione possa coniugare con coerenza la propria mentalità con gli atteggiamenti funzionali al cambiamento richiesto. Se manca questo anello di congiuntura, difficilmente le scelte si tradurranno in passi concreti.
Della formazione tutti ne parlano, ma pochi ne prendono sul serio le potenzialità e se ne prendono cura. Essa è precisamente lo spazio che consente ai soggetti di acquisire le competenze (non solo intellettuali) per riformare le istituzioni e a queste ultime garantisce la possibilità che i soggetti mettano in atto gli atteggiamenti e i comportamenti idonei a portarle avanti, dinamicamente. La formazione – intesa come integrale e condivisa (cf. Instrumentum laboris2024, 56-57) – è necessaria per affrontare le resistenze al cambiamento, per imparare a gestire i conflitti interni a sé e con gli altri, per stimolare quel cambio di mentalità essenziale ad apprendere nuovi modelli interiorizzati. Tante volte i processi di riforma non vedono luce perché non sono accompagnati da percorsi formativi coerenti o – peggio ancora – si da importanza alla formazione sui documenti, se ne invoca continuamente la necessità (l’espressione “c’è bisogno di formazione” diventa un mantra per non affrontare le questioni cruciali) ma nella prassi non si attuano proposte formative idonee agli obiettivi da raggiugere. Basti pensare al tema del discernimento comunitario. Non serve solo chiarire chi lo compie (i soggetti), non basta neanche definire che cosa fare (avere un metodo negli organismi di partecipazione), serve anche capire come acquisire le competenze perché questo processo avvenga realmente. Fino a quando non prenderemo sul serio la portata trasformativa di questo come, faremo fatica ad adeguare le strutture ecclesiali alle esigenze della sinodalità, così come faremo fatica ad intercettare l’azione dello Spirito, principio della vita sinodale della Chiesa, di ogni azione formativa, di ogni discernimento. Perché lasciarsi trasformare dallo Spirito non è un’operazione magica: implica la nostra libertà responsabile, alla quale spetta riconoscere ed eliminare gli ostacoli alla sua azione, per percorrere i sentirei che egli ci lascia intravedere.
Perdere l’equilibrio per iniziare processi trasformativi
Alla fine, l’azione dello Spirito consiste primariamente nello scompaginare i nostri soliti schemi per permetterci di riorganizzarli in modo nuovo, sempre più rispondente alla realtà di ogni tempo e di ogni contesto. È riconoscere il vento della Pentecoste ancora in azione. Iniziare processi trasformativi in una Chiesa sinodale vuole dire accettare di perdere l’equilibrio. Proprio come quando devi camminare: se non accetti di lasciare la sicurezza del terreno su cui poggi il piede e non accogli l’instabilità del portare avanti la gamba in uno spazio sconosciuto (che ti può far perdere l’equilibrio) e non provi a mettere il piede su uno spazio totalmente nuovo, non fai nessun passo in avanti. Resti semplicemente fermo. Questo passo lo dobbiamo fare tutti, nessuno escluso. Certamente i frutti di questi anni dipenderanno in grande misura dal documento finale del Sinodo dei Vescovi e delle assemblee sinodali italiane, dal papa e dai vescovi italiani, e da quello che decideranno di fare del discernimento avviato. Ma – non dimentichiamolo – in ultima analisi dipendono soprattutto da noi, dalle nostre comunità, da te e da me, e da quanto sceglieremo di metterci in gioco nei processi trasformativi di una Chiesa sinodale.
Giorgio Nacci è docente incaricato di teologia morale presso l’Istituto Teologico Regina Apuliae di Molfetta – Facoltà Teologica Pugliese. Attualmente è membro della Presidenza del Comitato nazionale per il cammino sinodale delle Chiese in Italia.








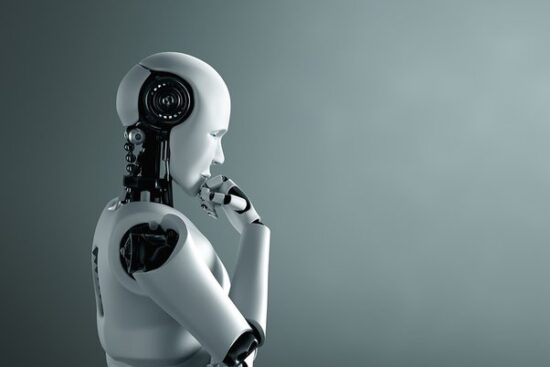
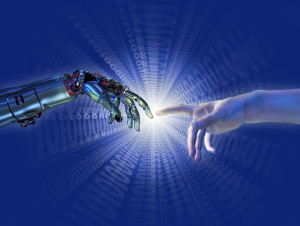

Lascia un commento