
Giorgio Nacci, dal 2016 presbitero dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, ha conseguito la laurea magistrale in scienze pedagogiche presso l’Università del Salento e il dottorato in teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. È docente incaricato di teologia morale fondamentale e di metodologia teologica presso l’Istituto Teologico Regina Apuliae della Facoltà Teologica Pugliese. Con Edacalf-LUP ha pubblicato il volume Formare presbiteri accompagnatori nel discernimento morale. Criteri per un progetto pedagogico. Con Roberto Massaro e Gianpaolo Lacerenza cura il blog di promundivita.it

Un rischio a cui prestare attenzione
Chi si pone come accompagnatore della coscienza credente deve essere consapevole di esercitare sempre un potere. Ce lo ha spiegato molto bene Gaia De Vecchi nell’ultimo approfondimento sul nostro blog. Nella sua accezione originaria il potere (dal latino potestas, “forza”, “signoria”, “potenza”) è la capacità dell’essere: tutto ciò che esiste ha il potere di produrre un effetto o di subirlo. Per Platone avere potere significa avere la possibilità di, poter raggiungere un fine, trasformare la realtà; dunque, contrariamente a quello che pensiamo di solito, questo concetto ha un’accezione positiva, ha una certa utilità.
Anche nel contesto di una relazione si può esercitare un potere, perché si ha la possibilità di influire su decisioni, scelte e opinioni altrui. Il rischio di scivolare in dinamiche relazionali nelle quali il potere di fare qualcosa si trasforma in potere sull’altro (quindi in dominio) è sempre possibile; lo è ancor di più quando la relazione si fa asimmetrica, come quella di accompagnamento. Il pericolo di servirsi anziché servire la coscienza è un aspetto su cui bisogna sempre vigilare.
Gaia ha definito il concetto di abuso di coscienza, evidenziandone quegli elementi che costituiscono delle spie di attenzione per riconoscerne la struttura; ha indicato, inoltre, alcune vie e attenzioni per prevenire l’abuso e sostenere l’esercizio di un’autorità matura, tra cui la formazione del popolo di Dio. Proprio questo aspetto vorrei approfondire nel presente contributo, dando una particolare angolatura: la formazione di chi si trova ad accompagnare le coscienze, che siano presbiteri, consacrati o laici.
La teologia morale può aiutare a prevenire forme abuso?
Nella nostra riflessione conviene indugiare ancora un attimo sul particolare significato che riveste l’abuso di coscienza: esso si configura come «una forma di violazione dell’intimità altrui, consistente nell’induzione nell’altro del proprio modo di giudicare e dei propri criteri di discernimento o della propria sensibilità morale (e penitenziale)»[1]. La particolarità dell’abuso di coscienza, rispetto ad altre forme di abuso, consiste nel fatto che la persona abusante «tende ad impossessarsi del giudizio di coscienza, soprattutto rispetto alle moralità delle scelte, annullando o deformando tale giudizio come frutto di un processo di progressiva sottomissione all’abusatore che può portare la vittima a identificarsi con la volontà dell’abusatore intesa come la volontà di Dio»[2]. Chi abusa della coscienza in senso spirituale reclama il posto di Dio, sostiene di sapere meglio dell’altro ciò che Dio vuole per lui. È una perversione della paternità che perverte inevitabilmente anche la paternità divina.
Che apporto può dare la riflessione etica alla prevenzione di un abuso? Non basta il prezioso contributo delle scienze umane? La teologia ha davvero qualcosa da dire? La risposta a questa domanda non è banale. Dalla particolare prospettiva con la quale intendiamo e descriviamo gli elementi in gioco nel giudizio morale della coscienza, dipende molto della cornice teorica che può alimentare o prevenire modalità relazionali abusanti, rafforzare o scardinare strutture sistemiche abusanti (ad es. vita di comunità religiose, vigilanza dell’autorità ecclesiale…).
Proviamo a considerare, ad esempio, il rapporto tra coscienza e autorità. Nella storia della morale, il pendolo della teologia della coscienza ha oscillato, fin dal medioevo, tra considerarla come semplice esecutrice di norme estrinseche o concepirla come il nucleo etico del soggetto, dove risiede la sua dignità. Lo stesso magistero, soprattutto quello post conciliare, presenta questa tensione nei suoi documenti. Se mettiamo in relazione il modo di considerare la coscienza con i modelli di accompagnamento e di esercizio dell’autorità, ci rendiamo subito conto delle possibili differenze e soprattutto delle conseguenze.
Restando fedele al dettame conciliare, anche alla luce delle recenti scoperte neuroscientifiche, la riflessione etica deve dare sempre più valore alla dignità inviolabile della coscienza come luogo vivo dell’identità personale integrale in cui avviene l’incontro intimo e personale con Dio, e in cui abita lo Spirito santo (cf. Gaudium et spes,16). In essa la persona scopre la legge divina alla quale deve aderire però senza alcuna costrizione (cf. Dignitatis humanae, 3). Chi accompagna deve ricordarsi che il rapporto tra ogni coscienza e Dio è un mistero che non si può conoscere dall’esterno (cf. Evangelii gaudium, 172); egli è chiamato a comprendere e a far comprendere alla persona quanto lo Spirito sta già realizzando in lei, prima di qualsiasi relazione di aiuto.
Se una coscienza matura non può certamente fare a meno di obbedire alla legge divina, non va dimenticato che l’obbedienza, «lungi da diminuire la dignità della persona umana, la conduce alla maturità facendo crescere la libertà dei figli di Dio» (Perfectae caritatis, 14). Coloro che chiedono l’obbedienza pertanto «devono farlo in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama, con rispetto, concedendo loro la dovuta libertà, così da rendere l’obbedienza davvero attiva e responsabile» (Ivi).
Perciò papa Francesco insiste molto sull’importanza di non sostituirsi mai alle coscienze (Amoris laetitia, 37) o ricorda che le norme morali a cui aderire non vanno imposte «come se fossero pietre» (Ivi, 49) scagliate a priori sulla persona. C’è un modo violento di presentare la verità morale che predispone a vivere una relazione di potere sull’altro, che blinda il giudizio di coscienza legandolo ai dettami dell’accompagnatore. In poche parole, anche il semplice modo di proporre l’adesione ai valori morali evangelici può favorire indebitamente una relazione o un sistema abusante.
Per questo motivo una teologia morale che dia importanza al discernimento della coscienza, facendone il cardine della formazione morale e della maturazione etica della persona, aiuta a superare l’etica legalistica e il pericolo che essa sia humus grazie al quale l’abuso di coscienza possa crescere indisturbato. Nel discernimento, infatti, non solo si tengono presenti tutti gli elementi del giudizio morale, ma viene garantita l’adesione libera e responsabile alla norma attraverso un processo di ascolto dello Spirito reciproco, del credente e dell’accompagnatore. Una teologia morale capace di dar spazio adeguato al discernimento non è “un problema”, ma una risorsa per evitare di incentivare su larga scala, nell’ordinarietà delle relazioni pastorali, un sistema abusante.
Questi pochi accenni possono farci già facilmente comprendere come la formazione teologico-morale di presbiteri, religiosi e laici non è irrilevante, ma costituisce un aspetto fondamentale della loro formazione e della prevenzione ad ogni tipo di abuso.
Formare formatori?
Perché l’accompagnamento spirituale si configuri come servizio alla maturazione di una coscienza libera e responsabile, la formazione degli accompagnatori deve assumere alcune istanze come prioritarie.
Innanzitutto, va ridefinita la configurazione identitaria del cosiddetto “direttore spirituale”. Evitare di utilizzare il termine direttore/direzione a favore di accompagnatore/accompagnamento, non è un semplice maquillage linguistico, perché può aprire a modelli rappresentativi differenti su questo ruolo. Se io immagino la persona che mi guida nella formazione della coscienza o il confessore come “uno che deve dirigermi”, sarò più facilmente propenso a riporre in lui la mia fiducia senza stimolare il mio discernimento. Se penso, invece, che egli sia un accompagnatore il cui compito è stimolare la mia libera responsabilità di scegliere e di determinare la mia identità davanti a Dio e agli altri, avrò una percezione diversa di quella relazione e anche del mio compito in essa. Questa sottolineatura non è banale: spesso chi abusa della coscienza non fa altro che rispondere a bisogni fragilità e bisogni inconsci della persona, creando un connubio pericolosissimo[3]. Più mettiamo il credente nella condizione di crescere da sé, più eviteremo questo connubio. La formazione deve sempre chiarire il profilo identitario dell’accompagnatore, prima di formare a questo ministero.
Nei percorsi formativi una forte attenzione va data anche ad alcune spie che diventano indicatori di modelli interiorizzati e di personalità predisposte a instaurare relazioni non mature. Una eccessiva rigidità, un profilo identitario che si nasconde dietro al velo del mistero, del sacro o del carisma individuale, dei tratti chiaramente narcisistici, l’instaurare relazioni dipendenti o il violare i confini relazionali, sono tutti elementi chiave non solo da osservare ma anche da inserire esplicitamente a tema nei percorsi formativi, soprattutto per chi si prepara al ministero ordinato. Chi vuole approfondire questi aspetti potrà trovare molto giovamento dalla lettura del recente testo di Céline Hoyeau[4]. Alla luce di alcune storie e ricerche ormai note, c’è da chiedersi come è ancora possibile che certi fenomeni individualistici e autoreferenziali, oggi palesati anche nell’utilizzo dei social media, possano ancora proliferare indisturbati nei nostri contesti ecclesiali. Non va dimenticato che l’autorità per fare il male è la stessa utilizzata per fare il bene; ciò che ci fa capire il possibile rischio della deriva abusante è proprio lo stile relazionale utilizzato, non il contenuto di quello che si propone.
La formazione, inoltre, deve considerare soprattutto due aree vulberabili strettamente legate all’identità della persona: la stima di sé e l’affettività. Una fragilità nella considerazione realistica di sé e una forte insicurezza possono determinare la ricerca di compensazione in un ruolo, da viversi in modo rigido, creando un circolo di reciprocità funzionale tra atteggiamento autoritario e gratificazione del bisogno di sicurezza. L’area del potere può diventare un elemento compensatorio dei bisogni affettivi dell’accompagnatore, soprattutto in ordine all’intimità e alla dipendenza. Se si invade l’intimità non esistono più confini e l’accompagnatore diventa onnipotente, mette in atto dinamiche di controllo, suscita continua compiacenza (ovvero immaturità nelle scelte).
Infine, la formazione deve tener conto di due elementi imprescindibili. Innanzitutto, far acquisire agli accompagnatori (anche ai confessori) gli elementi fondamentali per saper gestire un colloquio in maniera non direttiva, per suscitare la maturazione interiore della coscienza. Poi, suggerire la supervisione pastorale come luogo in cui l’accompagnatore sa mettersi in ascolto delle dinamiche personali innescate nelle relazioni con chi accompagna, così da evitare il più possibile forme di spiritualizzazione e di razionalizzazione che impediscono di accorgersi delle proprie fragilità e delle dinamiche di controllo e di abuso che si possono innescare. Per questo motivo la comunità ecclesiale deve imparare ad essere meno autoreferenziale, evitando ogni pregiudizio intellettuale e antiscientifico: senza un serio apporto delle scienze empiriche (soprattutto della psicologia, della pedagogia e delle neuroscienze) non è possibile strutturare percorsi formativi adeguati a prevenire gli abusi di coscienza.
Un impegno
Bisogna spendersi nel formare i formatori della coscienza? Si, e bisogna ripensare in fretta le nostre strutture formative per evitare che si creino ambienti sistemici e strutturali che continuino a perpetrare stili relazionali malsani e immaturi. Dobbiamo formare persone che siano solo a servizio delle coscienze, non che si servano delle coscienze.
Resta fondamentale il monito lanciato da Céline Hoyeau a conclusione del suo libro: «Molte domande restano ancora senza risposta. Spetta a ricercatori, teologi, storici, sociologi e psicologi studiare in modo ancora più sistematico le radici di questi abusi e mettere in luce le sfide che pongono alla Chiesa»[5]. E la Chiesa «deve attingere ancora una volta al tesoro della sua tradizione, alla sapienza monastica e canonica, per ricordare le modalità della giusta obbedienza che non è affatto una rinuncia alla propria libertà, e meno che mai l’annientamento della propria personalità. Si tratta di una sfida decisiva per tutta la vita cristiana, ma anche per la vita che è al mondo»[6].
______________________________
[1] A. Cencini – S. Lassi (a cura di), La formazione iniziale in tempo di abusi. Sussidio per i formatori al presbiterato e alla vita consacrata e per i giovani in formazione, Servizio Nazionale Tutela dei Minori della CEI, Roma 2021, 52.
[2] D. Cito, «Potere e abuso di potere nella chiesa», in Credere Oggi 43(2023)4, 126.
[3] Su questo aspetto cf. G. Ronzoni, L’abuso spirituale. Riconoscerlo per prevenirlo, EMP, Padova 2023.
[4] C. Hoyeau, Il tradimento dei padri. Manipolazione e abuso nei fondatori di nuove comunità, Queriniana 2023. Si veda anche Christus vivit, n. 98.
[5] Ivi, 277.
[6] Ivi, 283.







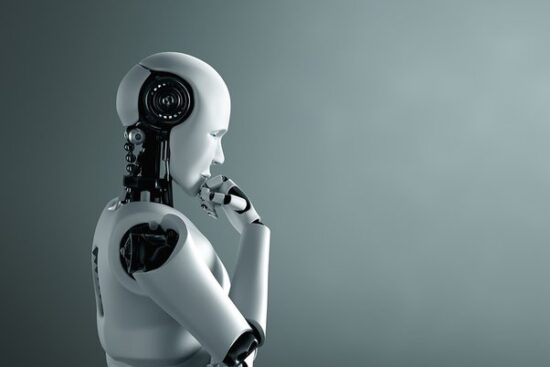
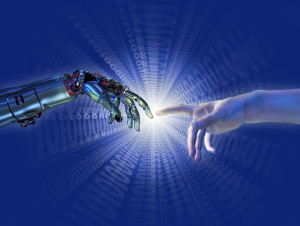

Lascia un commento