
Don Andrea Cardullo, presbitero. Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa (2001), la Licenza di Teologia Morale con indirizzo in Bioetica (2016) e il Dottorato in Teologia Morale (2023) presso l’Accademia Alfonsiana di Roma.
Attualmente, nell’Arcidiocesi di Lucca, ricopre gli incarichi di parroco, di direttore dell’Ufficio per la pastorale della salute, di consulente etico nel Consultorio di pastorale familiare, di responsabile degli studi nella Commissione per il diaconato permanente e di docente di teologia morale fondamentale presso la Scuola di formazione teologica diocesana.

La voce «Nutrizione e idratazione artificiali (NIA)» del Piccolo lessico del fine-vita (PLFV) della PAV ha suscitato due interrogativi in Emanuele De Michele, evidentemente consapevole del duplice compito della teologia morale: da un lato, fornire indicazioni normative capaci di rispondere alle istanze sempre nuove che continuamente emergono in un mondo in rapido sviluppo scientifico e tecnologico; dall’altro, assolvere questo compito pur mantenendosi all’interno del cosiddetto solco della tradizione.
Il PLFV ci mette di fronte a nuovi parametri decisionali?
A ben vedere, come già fatto notare dal prof. Guenzi, i parametri decisionali utilizzati dal PLFV non costituiscono una novità. Piuttosto, la novità dovrebbe essere colta nel modo di comprendere la fattispecie morale a cui i parametri in questione vengono applicati.
Fino ad oggi, affrontando il tema della NIA, il Magistero ne ha sempre parlato come di una cura minimale, ordinaria, normale, non solo evitando di ricorrere ai termini terapia o trattamento medico, ma anche arrivando a dichiarare esplicitamente che queste tecniche di cura «non costituiscono una terapia medica in senso proprio» (Samaritanus bonus). Questo dato, in realtà, non sorprende, dal momento che anche la comunità scientifica ha iniziato solo negli ultimi decenni a riflettere sulla comprensione della NIA come trattamento medico in senso stretto.
Allo stato attuale, tuttavia, «le società scientifiche principali definiscono unanimemente la NIA come trattamento medico-sanitario a tutti gli effetti» (PLFV). Pertanto, dal momento che tale definizione è di competenza della scienza medica e non della teologia morale, non sorprende che la PAV non solo faccia propria tale definizione, ma anche ne illustri la ragionevolezza: «in effetti, quanto viene inserito nell’organismo è preparato in laboratorio e somministrato attraverso dispositivi tecnici, su prescrizione e tramite interventi medici. Non si tratta pertanto di semplici procedure assistenziali» (PLFV).
Una volta ricompresa la NIA come trattamento medico a tutti gli effetti, fondare la riflessione morale circa il suo utilizzo sui tradizionali principi di «proporzionalità, disponibilità e appropriatezza clinica» menzionati da De Michele risulta essere ancora più appropriato di quanto non lo fosse in tutti quei precedenti documenti in cui si evitava di guardare alla NIA come a una terapia.
Questo cambiamento nella comprensione della fattispecie morale da cure minimali a «trattamento medico-sanitario a tutti gli effetti» (PLFV) non deve sorprendere, dal momento che non costituisce un unicum nella storia del Magistero e della teologia morale. Ad esempio, qualcosa di analogo è accaduto nei confronti della pena di morte, che è stata a lungo ammessa, almeno in linea di principio, perché sostanzialmente inquadrata come una forma di legittima difesa che la società poteva mettere in atto nei confronti di un ingiusto aggressore. Ma quando i mutamenti sociali hanno reso non più verosimile una tale interpretazione, il giudizio morale sulla pena di morte è cambiato radicalmente.
Pertanto, come una rinnovata comprensione della pena di morte ne ha modificato la valutazione morale, allo stesso modo il pieno riconoscimento della NIA come terapia permette di valutarne l’obbligatorietà morale ricorrendo, senza più riserve, ai medesimi principi morali utilizzati per ogni altro trattamento medico. È evidente che questo può condurre a valutazioni morali non del tutto sovrapponibili a quelle formulate in precedenza.
Come evitare il rischio del soggettivismo?
Relativamente a questo secondo interrogativo, occorre innanzitutto ricordare che sono proprio i principi tradizionalmente applicati al cosiddetto dovere di curare e farsi curare che legano la doverosità, la liceità o l’illiceità di una terapia medica (quale la NIA a tutti gli effetti è) all’intrecciarsi di elementi sia di ordine oggettivo che soggettivo.
Non posso, inoltre, nascondere come questo richiamo al pericolo del soggettivismo mi rimandi a quella reticenza ad accordare fiducia alle coscienze dei soggetti agenti che il numero 37 di Amoris laetitia segnala come limite della nostra sensibilità morale. In quel medesimo numero, papa Francesco esorta a impegnarsi in un lavoro di formazione delle coscienze, di modo che ciascuno possa scoprirsi responsabile della propria condotta morale.
Non si tratta di un insegnamento nuovo, quanto, piuttosto, di un richiamo ai fondamenti del nostro patrimonio morale, in cui la dimensione formale della moralità ha a che fare con il rapporto tra l’azione posta dal soggetto e il giudizio della sua coscienza. Si radica pertanto nella nostra tradizione l’idea che il paziente debba fornirsi di tutte le conoscenze necessarie alla formulazione del proprio giudizio morale e che tale giudizio (assumere o non assumere una determinata terapia), una volta formulato con rettitudine e sufficiente certezza, venga riconosciuto come regola prossima del suo agire.
Ciò significa che spetta al paziente, sulla base di una norma generale (che indica in linea di principio l’obbligatorietà della somministrazione, anche per vie artificiali, di alimentazione e idratazione), discernere se tale norma generale possa essere applicata anche al suo caso concreto. E questo discernimento dovrà farlo conoscendo e adottando quei criteri secondo i quali un intervento terapeutico, nelle diverse circostanze (oggettive e soggettive), può essere riconosciuto come doveroso, lecito o illecito.
Chiaramente, questa legittima e doverosa autonomia decisionale del paziente richiede un’adeguata comprensione del principio di autonomia. Questo principio non afferma che ciascuno, in forza della propria razionalità, è legge a se stesso, perché non si fonda sull’idea di una libertà assoluta, sganciata da ogni relazione. Il principio di autonomia afferma piuttosto che ciascuno, in forza della propria razionalità e secondo le capacità della propria razionalità, è chiamato a inserirsi nell’ordine della vita buona. E la vita buona di un essere umano che è persona, cioè individuo in relazione, ha sempre a che fare con la comunità e con quella realtà che chiamiamo bene comune, che è un diritto e un dovere di tutti. È proprio il bene comune che chiama tutti e ciascuno a far sì che l’esercizio dell’autonomia orienti ogni soggetto alla vita buona. In altri termini, alla scelta libera, autonoma del paziente, sono tenuti a collaborare, secondo ciò che gli compete, tutti coloro che al paziente stanno intorno, vale a dire i sanitari e i familiari.
Il rischio del soggettivismo, pertanto, non sta nel lasciare al paziente il compito di decidere se iniziare, non iniziare, proseguire, interrompere la NIA, ma piuttosto nel lasciarlo solo, nell’abbandonarlo, nel non metterlo, con il proprio contributo, nelle condizioni di poter formulare, con la maggior competenza che gli è possibile, il suo giudizio morale. Ma una volta formulato tale giudizio, «il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente [espressa come] consapevole e informata decisione» (PLFV).







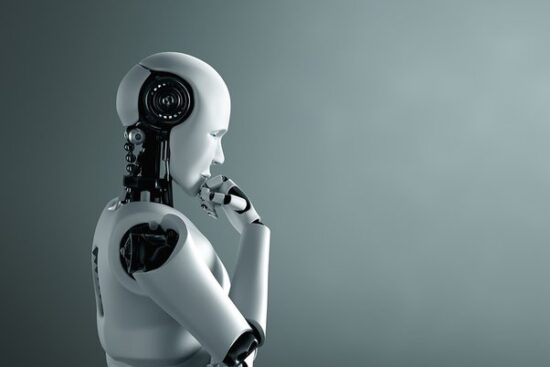
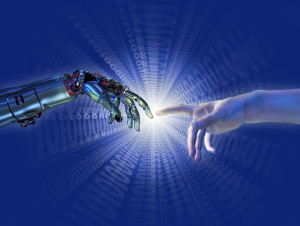

Lascia un commento